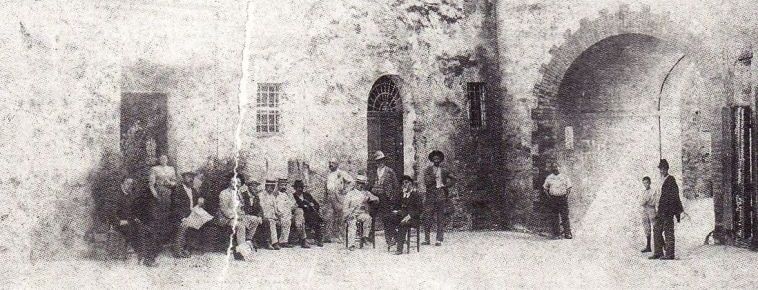⚔ Pillole di storia panicalese
Odoardo Farnese entra nel castello di Panicale
Testo tratto da Memorie Istoriche di Panicale, Terra Etrusco-Umbra, scritto da
Gustavo Grifoni nel 1918 e ristampato nell'anno 2000 per iniziativa dell'Associazione PAN KALON e con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, sotto il mandato del Sindaco
Dott. Daniele Orlandi.
[...]
Papa Urbano si rifece nel 1631 con l’occupazione di Urbino, lasciatogli dal duca Francesco Maria Della Rovere per via della sua debolezza senile. In questo triste periodo, la nostra sventurata Italia, già colpita dal flagello della guerra, dovette soccombere a un nemico ancora più terribile: la pestilenza. La nostra comunità non ne fu risparmiata. All’epoca, le epidemie contagiose erano frequenti, poiché i poveri abitanti, specialmente nelle campagne, vivevano nella più assoluta miseria e in condizioni igieniche spaventose. Le loro abitazioni non erano vere e proprie case, ma tuguri privi di luce e aria, catapecchie fetide e affumicate, dove uomini e animali domestici convivevano nello stesso spazio. L’egoismo regnava sovrano, e persino i magistrati papali ordinarono di sbarrare con cancelli tutti i borghi e i territori confinanti con la Toscana, in particolare Panicale e i suoi villaggi di Mongiovino e Tavernelle. Questo per impedire qualsiasi ingresso o uscita, condannando così quei poveri paesani a rimanere senza aiuti e senza conforto. Alla tragedia delle morti orribili si aggiunsero anche la scarsità di cibo e la carestia. Tavernelle fu sempre il paese più colpito dalle malattie contagiose, a causa della sua posizione in una zona bassa, della povertà degli abitanti, delle pessime condizioni igieniche delle abitazioni e del degrado delle strade.
Oggi, di quella miseria non resta più alcun esempio né alcuna memoria, perché, grazie all’impegno degli abitanti e degli amministratori comunali nel nuovo governo nazionale, le abitazioni e le condizioni igieniche del borgo sono migliorate notevolmente, rendendo Tavernelle uno dei centri abitati più vivi e accoglienti del comune.
L’ultimo colera che causò numerose vittime a Tavernelle, mentre Panicale ne rimase immune, si verificò nell’estate del 1856, anno che segnò anche il declino del dominio temporale dei papi. Lasciamo questo argomento triste e torniamo ai fatti del XVII secolo. Tra i Panicalesi dell’epoca merita di essere ricordato Girolamo Brunetti, nato nel 1570, che, dopo una lunga carriera militare, fu nominato capitano di Panicale, dove esercitò il comando fino al 10 febbraio 1645, giorno della sua morte. Durante il suo governo, Panicale subì gravi danni, ed ecco come avvenne. I nipoti di papa Urbano VIII (Barberini), noti per il loro carattere facinoroso e ambizioso, avevano scontentato molti principi, poiché il loro unico obiettivo era accrescere il potere e l’autorità della propria famiglia. Istigato da loro, il papa invitò Odoardo Farnese, duca di Parma, a recarsi a Roma, poiché, essendo anche duca di Castro (feudo della Chiesa), era considerato vassallo di essa. Odoardo accettò l’invito e fu accolto con grandi onori dai Barberini. Il papa sembrava apprezzarne molto la compagnia, essendo un principe colto con cui poteva discutere di letteratura e filosofia. Tuttavia, quando Urbano VIII gli propose di far sposare il suo primogenito con una sua nipote, il Farnese rifiutò risolutamente. Da questo nacquero sdegni, minacce e vendette da parte dei Barberini contro il duca. Taddeo Barberini, con circa 10.000 uomini, mosse contro Castro, lo assaltò e lo conquistò. Tutti i principi d’Italia si preoccuparono, temendo che la guerra si estendesse, e cercarono di mediare, ma senza successo, poiché gli animi dei contendenti erano ormai troppo esacerbati.
Odoardo Farnese non perse tempo e iniziò a radunare armi e soldati per la guerra. I fondi necessari gli vennero forniti dai Veneziani, dal Granduca di Toscana e dagli Estensi, con cui aveva stretto un’alleanza segreta. Mentre tutti si aspettavano che le milizie pontificie attaccassero lo Stato di Parma, il duca Odoardo, impaziente e impetuoso, con soli 3.000 cavalieri invase la vicina Romagna. Avanzando con rapidità fulminea, penetrò in Umbria e devastò le campagne e i villaggi della valle del Trasimeno, conquistando Castiglione del Lago. Quest’ultima avrebbe dovuto essere difesa da Fulvio Della Corgna, che invece si comportò in modo vile, arrivando addirittura a pregare gli abitanti di Castiglione di firmare la resa. Poco valoroso fu anche il comandante supremo, Federico Savelli, che non si mosse da Montalera con la scusa di avere poca artiglieria e di non sentirsi bene. Alla fine, cedette il comando e si ritirò a Perugia, dove l’ardore e il coraggio dei cittadini lo mettevano al sicuro. Questo abbandono facilitò ulteriormente l’azione militare del duca Odoardo, che poté operare con maggiore libertà e rapidità in tutto il territorio del Chiugino.
Infatti, il 2 ottobre 1632, la cavalleria del duca Farnese si diresse verso Panicale, Paciano e Piegaro.


Papa Urbano si rifece nel 1631 con l’occupazione di Urbino, lasciatogli dal duca Francesco Maria Della Rovere per via della sua debolezza senile. In questo triste periodo, la nostra sventurata Italia, già colpita dal flagello della guerra, dovette soccombere a un nemico ancora più terribile: la pestilenza. La nostra comunità non ne fu risparmiata. All’epoca, le epidemie contagiose erano frequenti, poiché i poveri abitanti, specialmente nelle campagne, vivevano nella più assoluta miseria e in condizioni igieniche spaventose. Le loro abitazioni non erano vere e proprie case, ma tuguri privi di luce e aria, catapecchie fetide e affumicate, dove uomini e animali domestici convivevano nello stesso spazio. L’egoismo regnava sovrano, e persino i magistrati papali ordinarono di sbarrare con cancelli tutti i borghi e i territori confinanti con la Toscana, in particolare Panicale e i suoi villaggi di Mongiovino e Tavernelle. Questo per impedire qualsiasi ingresso o uscita, condannando così quei poveri paesani a rimanere senza aiuti e senza conforto. Alla tragedia delle morti orribili si aggiunsero anche la scarsità di cibo e la carestia. Tavernelle fu sempre il paese più colpito dalle malattie contagiose, a causa della sua posizione in una zona bassa, della povertà degli abitanti, delle pessime condizioni igieniche delle abitazioni e del degrado delle strade.
Oggi, di quella miseria non resta più alcun esempio né alcuna memoria, perché, grazie all’impegno degli abitanti e degli amministratori comunali nel nuovo governo nazionale, le abitazioni e le condizioni igieniche del borgo sono migliorate notevolmente, rendendo Tavernelle uno dei centri abitati più vivi e accoglienti del comune.
L’ultimo colera che causò numerose vittime a Tavernelle, mentre Panicale ne rimase immune, si verificò nell’estate del 1856, anno che segnò anche il declino del dominio temporale dei papi. Lasciamo questo argomento triste e torniamo ai fatti del XVII secolo. Tra i Panicalesi dell’epoca merita di essere ricordato Girolamo Brunetti, nato nel 1570, che, dopo una lunga carriera militare, fu nominato capitano di Panicale, dove esercitò il comando fino al 10 febbraio 1645, giorno della sua morte. Durante il suo governo, Panicale subì gravi danni, ed ecco come avvenne. I nipoti di papa Urbano VIII (Barberini), noti per il loro carattere facinoroso e ambizioso, avevano scontentato molti principi, poiché il loro unico obiettivo era accrescere il potere e l’autorità della propria famiglia. Istigato da loro, il papa invitò Odoardo Farnese, duca di Parma, a recarsi a Roma, poiché, essendo anche duca di Castro (feudo della Chiesa), era considerato vassallo di essa. Odoardo accettò l’invito e fu accolto con grandi onori dai Barberini. Il papa sembrava apprezzarne molto la compagnia, essendo un principe colto con cui poteva discutere di letteratura e filosofia. Tuttavia, quando Urbano VIII gli propose di far sposare il suo primogenito con una sua nipote, il Farnese rifiutò risolutamente. Da questo nacquero sdegni, minacce e vendette da parte dei Barberini contro il duca. Taddeo Barberini, con circa 10.000 uomini, mosse contro Castro, lo assaltò e lo conquistò. Tutti i principi d’Italia si preoccuparono, temendo che la guerra si estendesse, e cercarono di mediare, ma senza successo, poiché gli animi dei contendenti erano ormai troppo esacerbati.
Odoardo Farnese non perse tempo e iniziò a radunare armi e soldati per la guerra. I fondi necessari gli vennero forniti dai Veneziani, dal Granduca di Toscana e dagli Estensi, con cui aveva stretto un’alleanza segreta. Mentre tutti si aspettavano che le milizie pontificie attaccassero lo Stato di Parma, il duca Odoardo, impaziente e impetuoso, con soli 3.000 cavalieri invase la vicina Romagna. Avanzando con rapidità fulminea, penetrò in Umbria e devastò le campagne e i villaggi della valle del Trasimeno, conquistando Castiglione del Lago. Quest’ultima avrebbe dovuto essere difesa da Fulvio Della Corgna, che invece si comportò in modo vile, arrivando addirittura a pregare gli abitanti di Castiglione di firmare la resa. Poco valoroso fu anche il comandante supremo, Federico Savelli, che non si mosse da Montalera con la scusa di avere poca artiglieria e di non sentirsi bene. Alla fine, cedette il comando e si ritirò a Perugia, dove l’ardore e il coraggio dei cittadini lo mettevano al sicuro. Questo abbandono facilitò ulteriormente l’azione militare del duca Odoardo, che poté operare con maggiore libertà e rapidità in tutto il territorio del Chiugino.
Infatti, il 2 ottobre 1632, la cavalleria del duca Farnese si diresse verso Panicale, Paciano e Piegaro.

Odoardo Farnese

Odorado Farnese
Gli abitanti di Panicale, colti di sorpresa, lasciarono entrare le milizie del duca all'interno delle mura della loro forte terra, anche su consiglio dei principali notabili del luogo, nella speranza di evitare mali peggiori. Tuttavia, quei soldati, resi arroganti dalla facile conquista, entrarono nelle case e vi commisero soprusi; banchettando e ubriacandosi, oltraggiavano le donne più belle e affascinanti, suscitando l’ira e la gelosia degli uomini del paese. Nicio Eritreo, in una sua lettera latina che descrive questa invasione, racconta come alcuni capi di una turma penetrarono nella casa di un’onesta donna con l'intento di farle violenza. La notizia giunse alle orecchie del fratello di lei, un frate appartenente all'ordine dei Francescani, che il Poliziano scherzosamente chiamava lignipedi per via degli zoccoli di legno che usavano come calzature. Il frate accorse immediatamente in casa e, non trovando altra arma, afferrò un randello che si trovava dietro la porta e, con tutta la forza possibile, colpì alla testa uno di quegli scellerati, stendendolo morto al suolo.
Consapevole della gravità del suo gesto, montò a cavallo, proprio quello che il soldato aveva legato alla porta, e fuggì per mettersi in salvo. Questo omicidio, insieme ad altri avvenuti nei dintorni del castello, scatenò l'ira del duca Odoardo, che ordinò di incendiare il borgo. Tuttavia, proprio in quel periodo, il Farnese si ammalò e dovette ricorrere alle cure di un medico.
Fu allora chiamato Carlo Sperelli giovane medico di Panicale di appena trent’anni, nato in una famiglia antica e benestante, eccellente nell’arte medica.
Già membro del Collegio di Perugia e protomedico di quella università, Sperelli era stato più volte consultato nei casi più gravi a Chiusi, Città della Pieve, Orvieto e nella stessa Perugia. Fortunatamente, riuscì a guarire il duca, che, riconoscente e colpito dalla sua dottrina e dalle sue maniere affabili, accolse le sue suppliche e ordinò che nell'incendio di Panicale venissero risparmiati la Chiesa Collegiata, l’archivio e la casa della famiglia Sperelli. Alla fine, solo un terzo delle abitazioni fu distrutto. Insomma, se Panicale non subì l’intera devastazione che gli era stata minacciata, lo deve ai meriti e all’amore del suo illustre cittadino, il dottor Carlo Sperelli.
Il duca Farnese avrebbe forse potuto continuare vittoriosamente la sua avanzata nello Stato Pontificio, se, giunto ad Acquapendente, non fosse stato persuaso dagli stessi suoi amici e alleati a tornare nei suoi territori, temendo un intervento della Francia e della Spagna. Tuttavia, nel 1643, a causa dell'ostinazione e dell'arroganza dei Barberini nelle loro inimicizie contro gli altri potentati d'Italia, si vide l'esercito del Granduca di Toscana avanzare nel territorio perugino, occupando Castiglione del Lago, Panicale e perfino Città della Pieve, nonostante fosse presidiata dal comandante Frizza Napolitano, che la difendeva per ordine di Urbano VIII.
All’invasione, i Barberini inviarono milizie nel territorio di Panicale, e sui colli di Mongiovino si scontrarono con i soldati toscani. Il combattimento fu inizialmente feroce e ostinato, ma poiché le truppe papali stanziate a Corciano non mossero in soccorso, i pontifici ebbero la peggio e furono costretti a ritirarsi. I Perugini non ebbero un ruolo significativo in questi scontri, poiché il papa, diffidando di loro, non li armò. I Toscani, per vendetta, dopo la vittoria riportata a Mongiovino, si abbandonarono a saccheggi e devastazioni in numerosi castelli; gli unici a essere risparmiati furono i Mongiovinesi, grazie al loro santuario. Si racconta infatti che i soldati toscani, pur essendo accampati per diversi giorni nei dintorni del tempio e sapendo che al suo interno erano state nascoste le ricchezze più preziose, non osarono penetrarvi per fare bottino. Anzi, lasciarono una cospicua elemosina per la celebrazione di alcune messe. Questo fatto è attestato da un documento giurato, redatto il 18 giugno 1644 da Giovanni Vergaro, pievano di Mongiovino, e conservato nell’archivio. L’abbondante offerta lasciata dai soldati toscani alla chiesa di Mongiovino era frutto della loro superstizione: credevano infatti che, in questo modo, potessero alleggerire la loro coscienza dai saccheggi, dagli stupri e dai massacri che avevano commesso altrove. Panicale fu uno dei luoghi che soffrì di più in quel periodo.
Ciò che Odoardo Farnese non riuscì a devastare, lo fecero i Toscani.
Mattia, maestro di campo dei Fiorentini, ordinò l’abbattimento delle fortificazioni, ee il granduca Ferdinando dominò la città per circa un anno, mantenendovi un presidio numeroso che doveva essere sostenuto economicamente dai poveri abitanti. Finalmente, il 31 marzo 1644, con la pace sottoscritta a Venezia, le truppe toscane abbandonarono il territorio
Il 21 novembre dello stesso anno, essendo già morto papa Urbano VIII, ritenuto la causa di tanti mali, i Panicalesi presentarono al suo successore, Innocenzo X (Panfili), una supplica del consiglio comunale per chiedere l’esenzione da dazi e gabelle, in compenso dei danni e delle spese subite, come era già stato concesso a Castiglione del Lago.
In questa triste e dolorosa epoca, il podestà di Panicale era Pietro Paolo Brancaleone, che ricoprì la carica dal 1640 al 1649, occupandosi con dedizione e grande impegno degli interessi della sua terra natia. Questa antica famiglia aveva già espresso altri podestà, come Ser Filippo, Ser Giuseppe e Ser Guido, a testimonianza della sua elevata posizione sociale.
Tra le famiglie illustri di Panicale vi furono anche i Vannucci, che fin dal XIV secolo annoverarono tra i loro membri tre giuristi e un letterato. Da un ramo di questa famiglia, trasferitosi nel territorio di Castel della Pieve, si dice che discendesse Pietro Vannucci, detto il Perugino, il grande maestro della pittura, che ebbe tra i suoi discepoli il divino Raffaello.